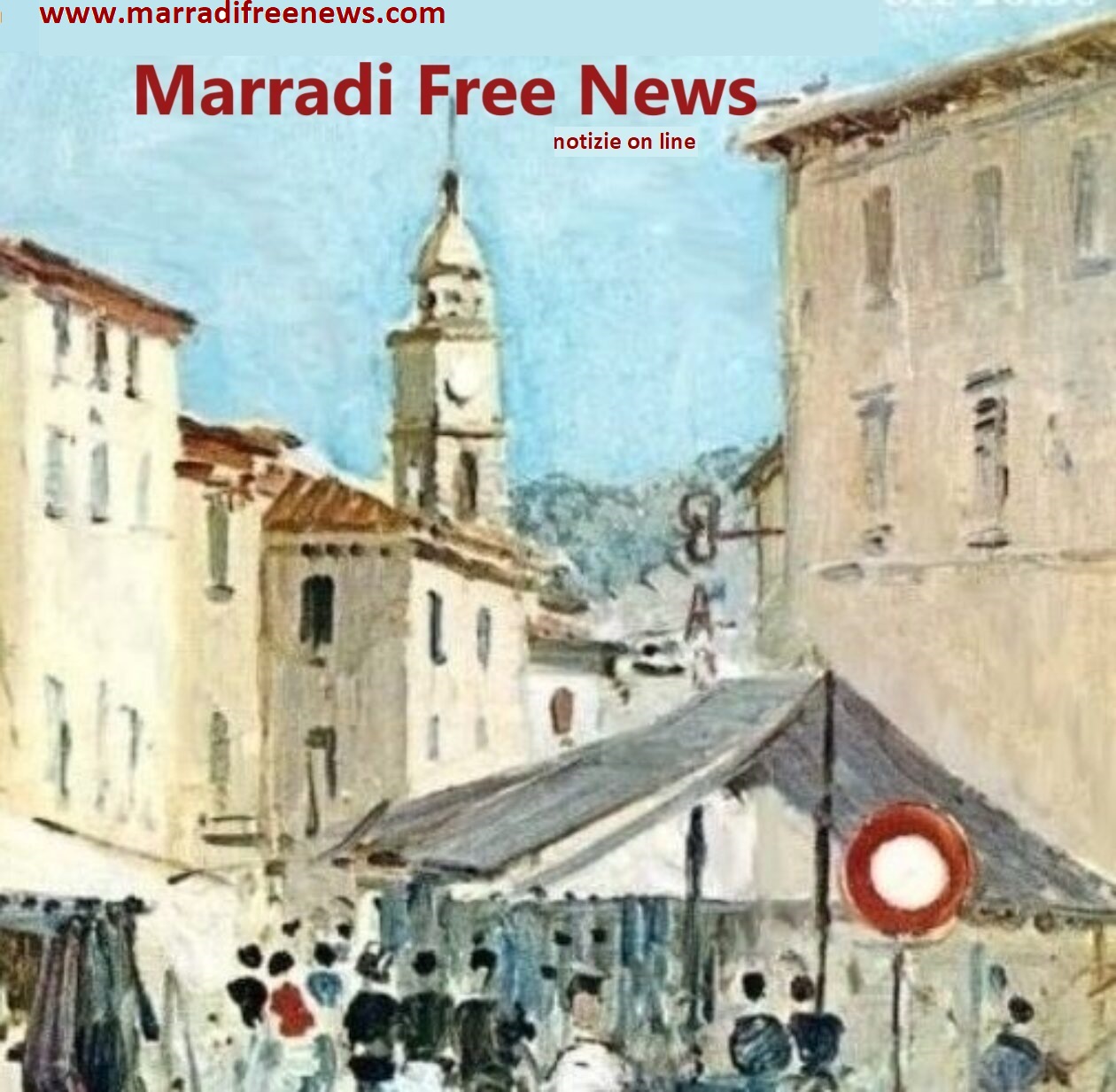Luigi Bandini, filosofo marradese, nel 1942, in pieno regime fascista, pubblica per l’editore Einaudi “Uomo e valore”, nel capitolo II “umana sostanza”, condanna l’umana degradazione compiuta in nome della “pretesa superiore dell’ente collettivo” che pretende di trasformare in gregario l’essere umano nel tentativo di ridurre l’individuo “a mero componente, ad una unità di una serie, di annegamento dell’individualità”. Mi piace ricordare come il libro di Bandini, che scrisse anche “Dalla massa all’individuo” si meritò il plauso di Benedetto Croce e Luigi Einaudi. Oggi la denuncia di Luigi Bandini resta di grande significato. Quante volte di fronte all’assunzione di responsabilità in direzione dell’etica e del diritto preferiamo ignorare il nostro destino attraverso distrazioni che aiutano a ridurre il nostro senso di isolamento, per esempio il “sesso, droga e rock & roll”. Oppure ci buttiamo nel lavoro o in un hobby, oppure nel conformismo, nel vivere come vogliono gli altri. Sicuramente possiamo ottenere una sensazione di immortalità collettiva attraverso l’azione comune e trarre conforto dal calore della massa, ma il costo è elevato: diventando parte della folla, il nostro io si dissolve prima ancora di morire. Harrington ha descritto tutto ciò come il “morire prima di morire” e il “suicidio a rate. Tragicamente, questo sacrificio dell’io razionale distrugge anche la nostra unica possibilità di salvezza. Alcuni reagiscono con furore. Condannati ad una troppo breve apparizione sul palcoscenico della vita, individui disperati adottano metodi sempre più assurdi per innalzare monumenti alla propria esistenza. Il dirottatore, il terrorista, il Kamikaze. A bene osservare nel rapporto fra cultura e politica, fra religione e politica, non ci si trova di fronte ad una opposizione, ma ad una coesistenza fra termini, al punto da poter ipotizzare un’interpretazione culturale della politica ed addirittura religiosa della politica. Nei Vangeli non si trova infatti né la condanna della realtà politica e neppure di quella economica. La fede autentica non si pone mai come rassegnazione, ma al contrario coinvolge il singolo pienamente nella vita quotidiana, al di là, però, di qualsiasi fondamentalismo. In questo orizzonte si colloca anche l’esperienza del Cristo, i cui insegnamenti si radicano nella cultura politica dell’Antico Testamento, a partire da quel «siate fecondi e moltiplicatevi» della Genesi che garantisce libertà politica ed uguaglianza a uomini e popoli. Infatti, più che di politica istituzionalmente ed ideologicamente intesa, nell’Antico Testamento ciò che interessa è il popolo, quale superamento della singola autocoscienza, morte dell’io e, come tale, realizzazione dell’ agàpe. Quest’ultima viene a porsi così nei termini di una vera e propria alleanza politica col Cristo e col prossimo. Si legge nel salmo 119, 10:«Sono straniero sulla terra; non mi nascondere i tuoi comandamenti» […] La differenza tra l’io e il mondo, si prosegue come obbligazione verso gli altri. Eco del dire permanente della Bibbia.

In quest’ottica politica culturale e cultura politica sono facili da scambiare, ma notevolmente diverse. Contro la politica culturale punta spesso il dito la sinistra che lamenta la scarsità dei mezzi destinati alla cultura strutturata e militante, che ammanta la politica, fine a se stessa, di involucri intellettualoidi e di falsi valori. I moderati prendono invece di mira spesso l’incapacità di focalizzare la cultura politica del centrodestra soprattutto in Italia ed in Europa. La differenza è sostanziale perché nel secondo caso, cultura non rappresenta soltanto un complesso di beni materiali e intellettuali, ma un paradigma di significati condivisi che si fa valore morale e prassi civile e sociale. La politica culturale è anzitutto una politica, e con il metro della politica va giudicata: valutando la capacità di mirare al bene comune, di gestire la complessa negoziazione tra gli interessi in gioco a vantaggio del maggiore numero possibile di attori coinvolti. In ambiti di così difficile gestione, come in generale nell’esercizio politico, l’abilità di raccogliere in una sintesi più alta esigenze trasversali rispetto agli schieramenti può diventare un fattore critico di successo. Nell’espressione cultura politica è invece la cultura a guidare. In questo contesto ha valore la capacità di alimentare un terreno condiviso, sul quale si innesta un’azione politica destinata a portare frutti duraturi. La sinistra riduce la cultura a strumento di propaganda per l’omologazione politica e punta all’ l’occupazione militare delle posizioni chiave dell’opinion-leading il campo dei riformisti moderati liberale offre, quando ci riesce luoghi di confronto per il garantismo, la deregulation, il riformismo istituzionale, la difesa dei valori identitari dell’occidente cristiano in una parola il liberalismo. Oggi la cultura per battere un colpo deve moltiplicare l’interesse sul dibattito prioritario sulla crisi dell’Occidente, mostrando con chiarezza che non bisogna cedere ad un falso progressismo, ad un modernismo relativo che vorrebbe liberarci da valori “obsoleti” in nome di una modernità coincidente con lo snaturamento e la triste omologazione planetaria di massa . Esiste invece una modernità autentica, che senza dimenticare le radici guarda al futuro. Ne è protagonista l’Io, un individuo libero, nel pieno dei suoi diritti, ma non isolato: è attraverso le relazioni fondamentali – la famiglia, la proprietà, il mercato – che egli costruisce la società civile. Procedere verso la modernità vuol dire sostenere lo sviluppo: impossibile senza rinnovare un patto produttivo, anziché scellerato, tra finanza e impresa, nell’ottica di un liberismo ben temperato. Ancora, modernità resta una parola vuota senza democrazia; occorre perciò all’interno appoggiare le riforme istituzionali, e all’estero promuovere l’evoluzione democratica, unica garanzia di stabilità internazionale e progresso. Così intesa, modernità spicca tra le parole chiave da diffondere e proporre all’area moderata e liberale. Concludendo il giusto rapporto tra intellettuali e politica, tra uomini di pensiero e partiti, tra operatori culturali e coalizioni politiche dovrebbe definire il legame tra la elaborazione delle idee e la prassi della politica. La politica sembra essersi mangiata la cultura perché con la sinistra è automatico che il rapporto si sviluppa secondo i canoni della pura strumentalità e della subordinazione, di una simbiosi o di un totale appiattimento delle ragioni della cultura a quelle della politica. Nel contesto di questo quadro generale, resta sullo sfondo il pesante condizionamento di una serie di pregiudizi, di equivoci e di complessi di inferiorità sui quali si è giocata la cosiddetta “egemonia culturale della sinistra” “talmente diffusa e soprattutto, si direbbe, così profondamente radicata, da trasformarsi nell’immaginario collettivo in una sorta di luogo comune metastorico” – secondo la quale i cosiddetti intellettuali sono “tutti di sinistra”.

Giovanni Raboni un intellettuale di sinistra che si era schierato pubblicamente con Rifondazione Comunista ha avuto il merito di andare alle radici del luogo comune e di dimostrare che è del tutto infondato: “molti, anzi moltissimi tra i protagonisti o quanto meno tra le figure di maggior rilievo della letteratura del Novecento appartengono o sono comunque collegabili a una delle diverse culture di centro-destra che si sono intrecciate o contrastate o coesistite nel corso del ventesimo secolo”. Alcuni nomi: Barrés, Benn, Bloy, Borges, Campana, Céline, Croce, D’Annunzio, T.S. Eliot, C.E. Gadda, Hesse, Ionesco, Jünger, Landolfi, Thomas Mann, Marinetti, Montale, Palazzeschi, Papini, Pirandello, Pound, Prezzolini, Tomasi di Lampedusa, W.B. NEL MONDO, Un elenco incompleto, del resto, e limitato al piano letterario. Basterebbe spostarsi, anche sul piano filosofico, politologico, antropologico, cinematografico per vedere l’elenco estendersi a dismisura. Raboni cita anche i tanti transfughi della sinistra che, folgorati dalla rivelazione dei disastri delle utopie giacobine e leniniste, hanno poi finito con l’attestarsi su posizioni di anti-sinistra tra questi: Gide, Hemingway, Maulraux, Orwell, Silone, Vittorini… Pasternak, Solzenicyn
Rodolfo Ridolfi